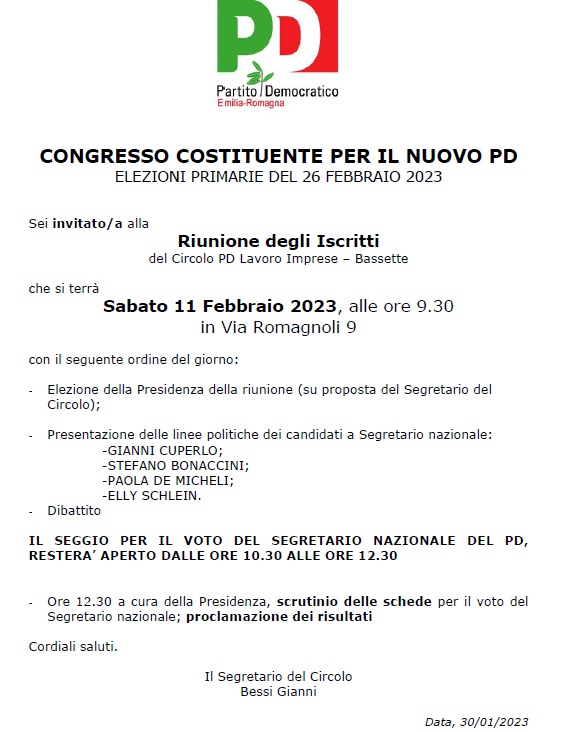Pubblicato su Startmagazine.it l’8 Agosto 2020
L’approfondimento di Gianni Bessi, Consigliere regionale Emilia-Romagna e autore di “House of zar – Geopolitica al tempo di Putin, Erdogan e Trump” (Edizioni goWare)
Lo shock globale del Covid-19 ha imposto all’Europa di decidere quanto prima come pianificare il proprio futuro. È una partita non solo politica e che non può essere giocata sul campo del consenso a breve termine, ma necessita di dialogo e di condivisione tra tutti i player coinvolti. A Berlino, visti i dati economici, sembra se ne siano accorti. A Roma… forse.
Il Recovery Fund e le altre le misure approvate dall’Ue mirano oltre il singolo intervento: l’obiettivo è invece di orientare le risorse collettive dell’eurozona per creare un’infrastruttura industriale ed economica sostenibile. Ci torna utile il modello di sostenibilità proposto da Onoranti in cui evidenzia come questo valore non sia una questione strettamente ambientale, ma indica invece una caratteristica trasversale di qualsiasi azione o fenomeno stabile nel tempo. Questa resilienza, che è parte di un sistema sostenibile, sarebbe un risultato di valore anche per le nostre economie. Così come il Green New Deal è una iniziativa per rispondere in maniera proattiva alla sfida ambientale, così il Recovery Fund fa della crisi un’occasione di evoluzione delle nostre strutture economiche e produttive.
Un cambiamento di paradigma di altro tenore rispetto alla crisi finanziaria del 2007 che fu affrontata invece con dogmatico liberalismo e con la conseguente rigidità normativa impedendo manovre finanziate con deficit di bilancio. Le due crisi presentano una differenza sostanziale: quella era primariamente finanziaria, questa lo è solo in seconda battuta e nasce da cause materiale evidenti.
L’urgenza è stata assicurare liquidità, ma lo sforzo maggiore per il sistema Europeo sarà quello di rafforzare le imprese con interventi straordinari. Anche a Berlino se ne sono accorti, nonostante la robustezza del tessuto imprenditoriale tedesco (la cosiddetta Mittelstand) rispetto a quello italiano. E a Roma? Forse.
Il decreto Rilancio ha assegnato veri e propri ‘superpoteri’ a Cassa Depositi Prestiti, che ora oltre a proteggere le aziende partecipate può estendere il suo intervento alle aziende con fatturato superiore ai 50 milioni di euro con lo strumento ribattezzato: Patrimonio Destinato, e che può rievocare l’Iri o una sorta di Gepi 4.0. Sempre CdP attraverso il Fondo d’Investimento Italiano ha varato FIMIC, una cassa da 800 milioni di € – come ha detto dal ceo di Fii Antonio Pace – per sostenere le filiere strategiche. Al Titolo II del Dl Rilancio ci sono le misure per le imprese finalizzate a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza: si va dalla regolamentazione dei contributi a fondo perduto al rafforzamento patrimoniale delle imprese di media dimensione, principalmente attraverso la fruizione dei crediti d’imposta. Può bastare?
Sicuramente è un passo importante, ma nello scenario post Covid-19, la capacità di attrarre investimenti del tessuto imprenditoriale rappresenterà un fattore dirimente per la tenuta della competitività di tutto il sistema.
Cogliamo l’occasione allora per una sosta a Bologna, nella piazzetta delle Sette Chiese dove all’ombra della calura estiva incontriamo Giulio Santagata, economista, già Ministro e Spin doctor di Romano Prodi, che davanti ad un tè freddo condivide utili riflessioni per il nostro viaggio nel Zeigsteit europeo.
“È noto, ci conferma Santagata, che la bassa capitalizzazione, la forma proprietaria prevalente e la situazione economica generale rischiano di impedire di fatto politiche di investimento strategico per quell’oceano di piccole e medie imprese che sono l’eccellenza del nostro sistema culturale ancor prima che economico, tanto da prendere il nome di ‘multinazionali tascabili’. ”
Necessità e urgenza nel trovare strumenti che favoriscano un reale salto qualitativo del sistema delle PMI, anche attraverso l’ingresso di capitali di private equity sono evidenti. Si tratta di meccanismi complessi che incontrano ostacoli insuperabili nella piccola dimensione delle imprese, nella struttura organizzativa caratteristica e nei sistemi proprietari tradizionali.
Santagata ci conferma “che i Fondi di private equity, sono interessati principalmente a investire in operatori economici maturi sotto il profilo della cultura finanziaria e trovano poco appetibili le piccole e medie imprese sia in relazione al rischio di impresa e, di conseguenza, alla capacità di vedere remunerato adeguatamente il proprio investimento, sia rispetto alle piccole dimensioni di investimento richiesto, che non consentono di operare in una scala congrua, rendendo altresì troppo elevati i costi di due diligence. A ciò si unisce una presunta difficoltà di smobilizzo delle quote investite determinata, tra l’altro, dalla tipologia dell’impresa target e da una scarsa familiarità da parte del tessuto regionale con gli strumenti tipici degli operatori di private equity.”
Consapevoli che il confronto sia forzato ma tali difficoltà non riguardano la Germania perché da diverso tempo ha aperto il suo mercato finanziario e il suo sistema delle imprese agli investitori istituzionali. Berlino ha mobilitato il suo proverbiale sincretismo politico, culturale ed economico grazie alla solidità della governance di impresa e alla sorprendente ‘mitbestimmung’, cioè la cogestione tra capitale e lavoro nei consigli di sorveglianza delle imprese.
Il rischio per l’Italia è di trasformare una necessità di azione in un’occasione – l’ennesima – di dibattito. In particolare del tipo privo di qualunque concretezza, e tutto incentrato sulla nostalgia dei bei tempi andati. Belli o no che fossero… sono andati! Un atteggiamento che denuncia la senescenza di una classe dirigente non sempre al passo coi tempi. La “retropia” di cui parla il Bauman calza a pennello per descrivere il mood nazionale rispetto al tema dello Stato imprenditore. La diversità di opinione è l’essenza stessa della democrazia e il confronto ne fa parte. Resta tuttavia una domanda: in un mondo dove gli Stati fanno parte del tessuto economico delle nazioni, in una congiuntura storica con molti tratti di unicità e tale da aver determinato ad un rapido ed incisivo intervento anche da parte di paesi, come gli Usa, che ostentano la bandiera del liberalismo più rigoroso, che lo Stato (e aggiungiamo l’Ue) si tenga un passo indietro è ancora un’opzione?
“In tale contesto servono azioni, consiglia il già Ministro dei governi dell’Ulivo. che potrebbero contribuire a superare tali elementi di mismatch e stimolare la presenza di capitali di investimento per rafforzare il nostro capitale nazionale: le piccole e medie imprese.”
L’economista riassume in tre punti chiave le linee di intervento che propone per il comparto manufatturiero di cui è profondo conoscitore: alimentare l’interesse finanziario e il capital gain dei fondi di private equity, contribuendo a comporre congrui volumi di investimento con l’individuazione di gruppi di PMI potenziali nell’ambito delle filiere produttive principali; implementare forme di garanzia affidabili per lo smobilizzo nelle fasi di disinvestimento; rendere economicamente più sostenibili le due diligence.
La soluzione si trova sotto i nostri occhi: è necessario un impegno comune del sistema politico e industriale affinché siano realizzati elementi di attrattività dei capitali — nazionali e non solo — verso la catena del valore made in Italy nel suo complesso e non unicamente per i suoi prodotti, ma anche per le sue infrastrutture. Elementi che in buona misura non si tratta di creare ex novo ma di rendere coerenti con lo spirito, le esigenze e la tecnologia del nostro tempo.
Il viaggio continua. Prossima tappa l’asse Karlsruhe-Francoforte: sovranità e moneta.